
Mestieri e Radioso Futuro
- 21 Novembre 2014 - 9:39
- 8
Ho capito una cosa di questo Paese/Italia, esso è essenzialmente conservatore. Bella scoperta, mi si dirà, l’acqua calda! E non legittimo una difesa alla mia ingenuità neanche se dico che anche la sinistra progressista è spesso conservatrice e le elite culturali – anche quelle di sinistra – sono aristocratiche. Non cito neanche i fenomeni legati al pensiero liberale perché in Italia non esistono più da tempo (mi chiedo se siano mai esistiti) e nemmeno quelli talvolta drammaticamente da macchietta delle posizioni estreme (destra e sinistra, per me pari sono). Allora, chiarito che anche per me, come per Consalvo Uzeda, il partito in Italia è unico, ed è tutto dedito alla conservazione dei privilegi, non resterebbe altro che aderire alla posizione estetica. Purtroppo l’estetica è ambito di cui già si è appropriata una certa classe dirigente, manifestandola persino quale etica per mezzo di talune fictiones più o meno coscienti (meno, nel caso degli insulsi traffichini da codazzo). Dunque si dovrebbe intraprendere un lungo, lunghissimo, dibattito inteso a chiarire perlomeno in maniera accettabile un’etimologia e un significato assumibile comunemente, aprioristicamente, per i termini: estetica, retorica, etica, formalismo. Non è mia intenzione farlo in questa sede, non ne avrei le capacità, e mi scoccia pure un poco.
Da questo punto, per giungere al nichilismo, il passo è veramente breve. E se devo essere sincero, seppur mi dovessi pensare in qualche modo attirato dal mandare a quel paese tutte le cose che in maniera arrogante interpreto come negative, non credo che essa alla fine risulterebbe la migliore delle scelte. Soprattutto perché i nichilisti mi stanno antipatici. Mi segua il lettore volenteroso, ancora per un attimo, non si infastidisca, offrirò una soluzione o la parvenza di esso. A cosa mira l’umanità? Io ho parecchi dubbi su quanto sia legittimo credere che il fine ultimo dell’uomo possa essere il lavoro, l’occupazione seriosa e produttiva, nell’attesa di una assegnazione premi dall’alto dei cieli. Una specie di premio per aver impiegato tutto la vita a caricare la schiena, talvolta sino al punto di spezzarla? A parte il fatto che sono estremamente dubbioso sull’eticità di un sistema che preveda il ringraziamento per l’occupazione da parte del lavorante nei confronti del datore di lavoro, quando la possibilità di trovarsi occupati dovrebbe pacificamente essere di assoluta normalità nel vivere quotidiano, sono abbastanza propenso a credere che il fine dell’uomo sia invece, o dovrebbe essere, una media felicità consortile (un amico mi suggerisce che si dovrebbe rincorrere il benessere comune e non il bene comune). Questa l’utopia! Cari umani, cari lettori, non sarà mai così. Purtroppo, lo dico anche a me stesso, tali vane speranze saranno sempre irraggiungibili. L’uomo che insegue la felicità, di fatto, deve spesso farlo, o a discapito di altri (opzione che non mi sento di consigliare), oppure integrando tale ricerca nel disegno personale di generale disinteresse per la società. Sembra una scelta di destra (individualista), in realtà non lo è. Chiariamolo, ciò che è impossibile va comunque assunto come da realizzarsi in futuro, altrimenti si finisce per appendere il cartello “chiuso” e si fa come quegli eretici che, per liberarsi totalmente dalla corporeità del peccato, eliminavano il problema alla radice (non è consigliabile). Una gran fesseria, se posso esprimermi. Preferisco far finta di non aver capito, e continuare a stare al gioco della vita sociale, magari con la beata stupidità di chi cerca di migliorare egoisticamente il contesto in cui vive. Su tale ultima possibilità si innesta l’eventualità del disinteresse sociale. Ossia: e se a un certo punto preso dal più totalizzante degli egoismi cominciassi a fregarmene anche del contesto? Ovvio, alla fine si vive comunque nel contesto. Ma ammettiamone la possibilità e ammettiamo chi ci si annoi definitivamente di fingere pacifici e supini sorrisi di circostanza alle ragioni dei traffichini da codazzo, di fingersi più stupidi di quanto si è. Si arriva così al punto nodale della discussione: in ogni caso, il disinteresse sociale necessita di una rendita, altrimenti non è perseguibile.
La settimana scorsa, mi sono fermato a parlare con un altro amico (non era quello del “benessere”) – anch’esso si poneva i miei stessi dubbi: serve fare qualcosa? (la domanda è posta proprio nel senso più generale possibile) – e alla fine abbiamo fatto un breve elenco di mestieri (etimologia fantastica: da mesto) che in teoria dovrebbero consentire il disinteresse sociale, pur nella piena tranquillità economica. Lo riporto di seguito:
– Rockstar di fama planetaria.
– Onorevole presso il Parlamento italiano.
– Omosessuale di notorietà televisiva, anche finto va bene (non me ne vogliano a male rappresentanti e sostenitori della lobby, lo so che è pericoloso fare ironie sulla gaiezza, a rischio di pesanti anatemi. Mi pento e mi dolgo. Ma ammetteranno gli interessati che tale indirizzo sessuale fa ormai tendenza nel mondo dello spettacolo).
– Calciatore in serie A con velina annessa.
– Personaggio dei fumetti.
– Astronauta che non vuole ritornare.
– Attore/attrice porno che scrive su MicroMega.
– Il prete.
– Scemo del villaggio che si fa mantenere dai suoi genitori, anche finto va bene (la differenza col punto di partenza sta nell’assimilazione totale).
Su tale ultima allettante opzione mi fermo, in ordine agli incentivi statali costituiti in merito.
Gaetano Celestre








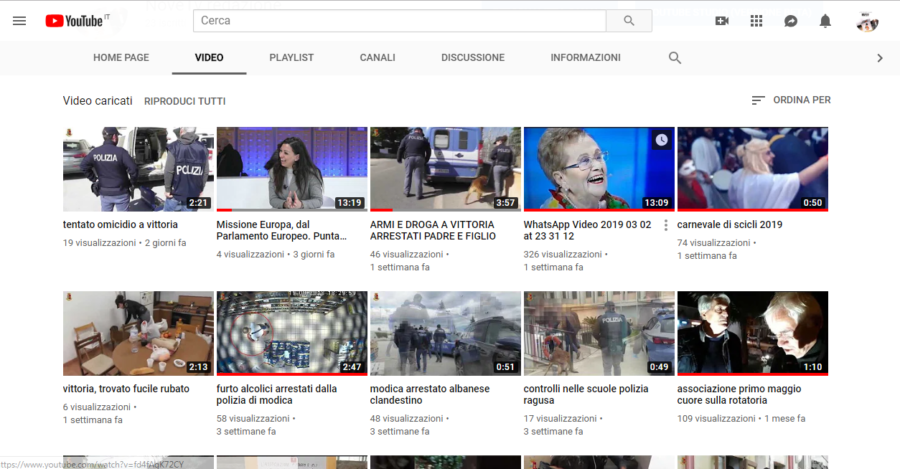
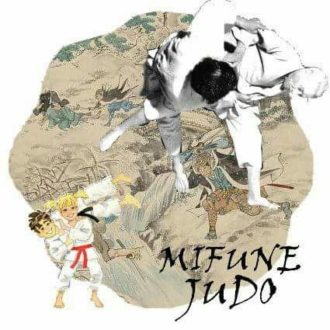



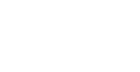
Maurizio
Gaetano,
ammetto che non riesco a ricamare, con la tua abilità, su questa trama di ragionamento che hai intessuto.
Come nelle “favole”, forse in maniera semplicistica, stavo cercando la morale dello scritto.. e mi sono perso nel bosco.
Credo – e ribadisco il credo – possa essere che la società si sta annichilendo (verbo riflessivo? Non so) colpa dell’egoismo di destra che blocca lo sviluppo delle felicità. Stando così le cose, la miglior cosa è costruire un fortino, infilarcisi dentro e sparare contro chi porta novità, innovazione, benessere, ecc ecc (che, per contrasto tra i vecchi schemi semplificati, dovrebbe essere la mission della sinistra)
Sul tema, ho trovato uno scritto di un prof, che in quanto tale ha maggior valore del mio, che riporto in calce. (pubblicazione su Il Corriere del Mezzogiorno/corriere.it)
Prima annoto solo che il premio promesso dall’alto al lavorare, di cui dici (deificazione), è promesso non per il lavoro svolto, ma per la glorificazione Dei.
Quindi, anche un disoccupato – esempio un prete/pastore/himam – sarà premiato dall’alto (Alto).
In ogni caso, il “povero” salariato – vessato per definizione – non ha nessun diritto naturale alla occupazione, come dici tu. Esiste in sua vece, un dovere di essere utili alla propria comunità.
Solo da qualche decennio ci sono cascate di “diritti” a scapito di rigagnoli rinsecchiti di “doveri”. Qualche decennio fa – da fine ‘800 indietro, esempio – avevi un ruolo solo se servivi alla sopravvivenza della tua comunità di appartenenza. Quello era l’essenza del “benessere comune”, che tu e il tuo amico evidenziate. (salvo storture sempre presenti nei casi umani)
Oggi, si ha valore solo per il fatto di essere Essere Umano (probabilmente una evoluzione nei termini).
Concludo, prima di lasciare la parola al prof. Paolo Macry, che un salariato esiste in quanto esista un datore di salario e viceversa. Per cui, detta volgarmente, sono tutt’e due nella stessa barca e se affonda, crepano assieme: non c’è un più eletto ed un più reietto.
con affetto,
Maurizio
..
testo tratto da Il Corriere del Mezzogiorno / Corriere della Sera – di Paolo Macry
Gli scontri di Bagnoli
Fuochi di protesta emergono nella metropoli napoletana, sono gli abitanti dell’Acerrano, la folla che manifesta a Bagnoli, gli irriducibili addetti al sito di Pompei. Propongono alternative di governo? Agitano lo spettro della rivoluzione? O sono i reazionari del Terzo Millennio?
Si dirà che i fenomeni antagonisti – dai movimenti globali Occupy agli italiani NoTav – sono da tempo moneta corrente.
Qui, tuttavia, essi appaiono come scarnificati, ridotti all’osso delle proprie contraddizioni, privi anche di quell’aura utopica che sempre avvolge le tensioni rivoluzionarie. Il che deriva dall’abisso esistente fra gli obiettivi della «lotta» e le condizioni del contesto.
A cosa si oppongono infatti gli episodi di conflittualità esplosi ultimamente a Napoli?
A una soluzione del problema dei rifiuti. Alla messa a profitto dell’area di Bagnoli. Allo sviluppo del turismo di massa. Alla costruzione di centrali elettriche. Alle trivellazioni in Campania.
Ovvero a ogni ipotesi di accrescimento della ricchezza locale. Che nel frattempo il contesto viva una crisi strutturale gravissima sembra questione lontana.
Gli antagonisti ignorano la città che si sbriciola al primo acquazzone e le periferie dominate dalla camorra.
Appaiono disinteressati agli effetti occupazionali dell’edilizia, allo smaltimento delle ecoballe, alla ricostruzione dell’ambiente. Mischiano presunti interessi locali con parole d’ordine anticapitalistiche, antitecnologiche, antimoderne.
Sono cioè, in senso stretto, reazionari.
Tutto questo richiama un nodo storico.
In Italia, il conflitto sociale ha avuto caratteri controversi. Ha consolidato e legittimato la democrazia, con le battaglie otto-novecentesche per i contratti agrari, il lavoro di fabbrica, i diritti civili, eccetera.
Ma ha anche pascolato, più che in paesi come l’Inghilterra o la Germania, all’ombra di partiti e sindacati nazionali che non di rado ne manipolavano programmi e interessi.
E visto che si trattava di partiti massimalisti o comunque all’opposizione, come il Psi primo-novecentesco o il Pci, il conflitto sociale è stato ambiguo nei confronti dei processi di trasformazione, del rapporto tra sviluppo e uguaglianza, del nesso tra Stato e mercato.
È apparso, non di rado, conservatore. Incapace di stare al passo coi tempi.
Oggi, dato il collasso di partiti e sindacati, il conflitto non ne succhia più gli umori conservatori. Ma l’esito è assai dubbio: quegli umori conservatori stanno diventando umori reazionari.
Il cuore dell’antagonismo è ormai il rifiuto di ciò che una volta si sarebbe chiamato progresso.
La rivendicazione di uno status quo, che a Napoli significa degrado urbano, periferie miserabili, criminalità.
Il no radicale all’analisi dei problemi e alla ricerca di soluzioni.
Invece che battersi per la trasformazione della polis , il conflitto mostra di averne paura. Preferisce che nulla si faccia.
Un’opzione che rasenta il nichilismo.
—
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/politica/2014/10-novembre-2014/gli-antagonisti-sinistra-ecco-chi-sono-nuovi-reazionaria-230507065580.shtml
Gaetano Celestre
Caro Maurizio, io ho l’impressione che in questa società uno dei limiti maggiori sia rappresentato dalla volontà, quasi il bisogno interiore che si sente insorgere dentro, di cercare una morale, un rapporto escatologicamente etico, ordine e disciplina praticamente, in ogni cosa. Spesso le cose che accadono, o si scrivono non hanno finalità altra che starsene lì, accadute, scritte. Riguardo la questione del “premio”, il discorso è speculare, non è il fine che cerco di mettere sotto l’attenzione della coscienza (senza voler essere moraleggiante, si intende), bensì il mezzo. Buone cose.
Maurizio
ah scusa. pensavo fosse per discutere di qualcosa 🙂
A vossja!
Gaetano Celestre
A Maurizio. Ma vedi, è sempre per discutere di qualcosa. Che altro ci resta se non discutere? Come al solito, mi intrometto per evidenziare un’inezia, ossia la possibilità che la discussione non abbia scopo, e sia in essere per solo vezzo estetico. Che poi, nell’individualità, qualcuno assuma una parte delle discussioni come metro per giudicare la propria azione, questo è accidentale, e incidentalmente valutabile. 😉
Gaetano Celestre
E in effetti stiamo discutendo. 😀 mi sembra interessante, no?
Cinà
Forse, caro Gaetano, siamo naufraghi da una sorta di romanticismo tardivo in cui è tramontato il sacro, e con lui forse anche l’umano, viviamo nel tempo “dell’esodo di massa dal destino” che abbiamo sostituito con una miriade di surrogati – il potere, il lavoro, la fama, l’amore, la tecnica – illudendoci che, una volta dichiarate la fine della storia e la perdita dell’eterno, il piacere di sentirsi disormeggiati ci avrebbe restituito la libertà, ma ci ha lasciato in balia del caso e del non-senso, un tiranno più cieco e più folle, consegnandoci agli oracoli e agli oroscopi. In realtà l’impasse è a monte ed è ravvisabile essenzialmente in un deviato concetto di libertà, intesa come liberazione da, ossia rescissione da ogni legame umano e trascendente. Quando invece la libertà autentica si fonda su una previa obbedienza, in quanto l’uomo sarà libero a partire dalla sua dipendenza rispetto a qualcosa che lo supera e lo trascende e dal quale emerge parzialmente. Contrariamente all’opinione comune, il destino quindi non è il carcere del libero arbitrio perché il suo compiersi appartiene all’umana libertà.
L’orizzonte del destino non espropria l’uomo della sua vita inchiodandolo al reale duro e petroso, non lo affranca dall’assunzione delle responsabilità – casomai dalla nevrosi dell’esito del suo agire, successo o fallimento – ma gli restituisce l’ordito, coglie i nessi e non lo abbandona alla pura, occasionale esperienza, chiamandolo a rispondere di sé in relazione a un disegno. Alla teologia del carpe diem, al nichilismo gaio, alla tirannia degli istinti e degli istanti, non rimane che rispondere con il pensiero, sereno ma non quieto, rivolto al destino, manifesto dell’oggettività che libera dalla dittatura del soggettivismo e dal pensare relativo, senza fondamenti. La risposta non può che consistere nel dire sì alla vita, disporsi con fiducia a ciò che la nostra libertà non dispone, esprimere il nostro consenso profondo a quel che verrà e a quel che già ci costituisce.
Viceversa, negarsi al destino significa negare un’evidenza, dunque peccare di irrealismo, e scivolare nel regno del caso – o caos, suo anagramma – schiavi della precarietà e della indeterminatezza delle infinite possibilità, dove tra essere e il niente non c’è sostanziale differenza.
Gaetano Celestre
Carissimo Cinà, la discussione mi intriga. Quando insorse l’accusa che un dio onniveggente rendesse inutile la provvidenza (cioè un’entità previdente), la scolastica medievale rispose che erano sbagliati i presupposti, i punti di vista. Dio inviava la provvidenza da un piano a-temporale, di infinita contemporaneità se vogliamo, dove tutto quello che accade agli umani è già passato (come per gli indovini greci) ma essa agiva poi sulla limitatezza temporale terricola, per cui operava,una previsione futura. La difesa, seppure interessantissima, fu poi superata da altre opposizioni. È come per l’argomento ontologico, credo che la cosa più giusta di quella teoria tomista sia l’individuazione di dimensioni spazio temporali diverse. Ne deduco che qui sulla terra viviamo di inganni, se rapportiamo a dimensioni che pretendiamo superiori. Tutto da verificare. Resta invece da valutare se gli inganni possano solo essere considerati negativamente. Io non lo credo. È utile crearsi dei beati inganni, dei sogni, persino irrealizzabili. Le città cinquecentesche nascevano intorno a nuclei ideali (la chiesa, la piazza, la torre), era un’idea, un inganno, ma ha lasciato prospettive estetiche piacevoli. Le nostre periferie invece?
Cinà
Mi fa piacere, caro Gaetano, che le mie piccole riflessioni ti abbiano spinto verso quei territori che oggi si avviano mestamente alla desertificazione, prima si diceva “esodo di massa dal destino” ed approdo nelle sabbie mobili dei tanti surrogati.
Ti riferisci alla scolastica medievale che mosse i passi verso lo “gnoseologismo” o, preferibilemte, “dualismo gnoseologico” che trovò in Cartesio ed Hobbes i due architetti di una potente visione dell’essere e del pensiero secondo una dicotomia per cui il pensiero non sarebbe una manifestazione dell’essere, bensì “idea” (una copia più o meno fedele) dell’essere. Una prefiguazione, ossia una proiezione del senso comune su ciò che si da a vedere. In altre parole, con il dualismo gnoseologico il pensiero viene spazializzato come se fosse qualcosa dotato di un “dentro” e di un “fuori”, in una costruzione in cui l’idea è intesa come copia della realtà, realtà che invece è il “fuori” ossia la “realtà in sè”; a questo mi sembra conducano le tue ultime frasi:” qui sulla terra viviamo di inganni, se rapportiamo a dimensioni che pretendiamo superiori (…)È utile crearsi dei beati inganni, dei sogni, persino irrealizzabili.”
Chiudo questa mia sottolineatura con un pensiero di Antonio Rosmini che completamente condivido:
“La filosofia non comincia da alcuna proposizione supposta, ma da un punto luminoso, che ha l’evidenza della necessità(…).Né si può opporre che essendo l’intuizione facoltà dello spirito, con la quale si coglie quel punto di evidenza, e non essendone ancor provata la veracità, c’è la supposizione che non inganni, infatti è nella natura stessa dell’essere che si trova la sua necessità (…). L’essere è dunque quel solo che non ha bisogno d’altro che di se stesso per essere pensato ed ammesso come evidente e necessario”.