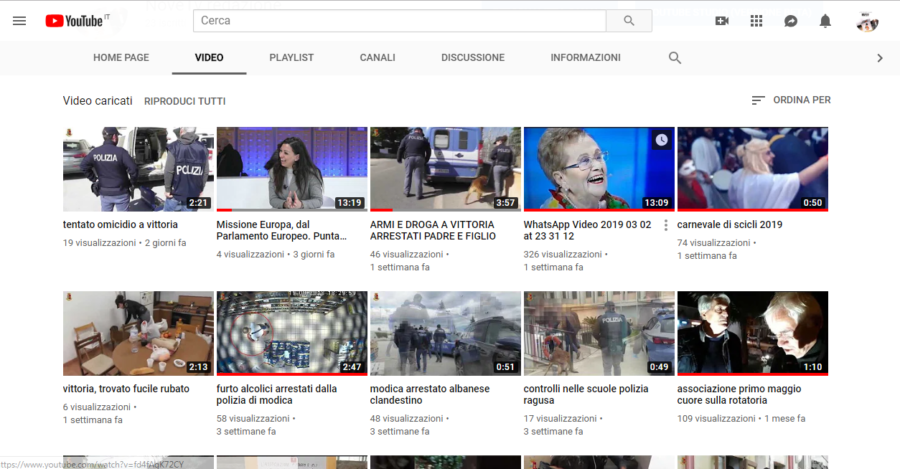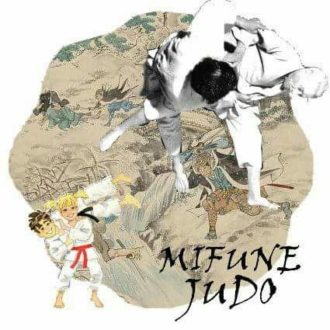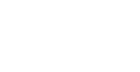Alberi e Uomini
- 29 Novembre 2016 - 22:24
- 0

“Eravamo tristi altre volte al pensiero che la razza dei giganti fosse scomparsa…” (Alberto Savinio)
Starei ore a guardare i rami di un albero, che sia un sempreverde o che muti vestito al trascorrere delle stagioni. Mi affascinano le architetture delle piante più semplici, che vi sia o meno un qualche tipo di coronamento floreale. E provo gran timore alla vista dei bulbi quando, per qualche caso, per una evenienza incidentale precedente alla mia percezione, capita di trovarne qualcuno fuori dall’alveo materno della terra. Mi sembra quasi di violarne la misteriosa intimità fetale, misterica ardirei, in analogia alla funzione e figura ovulare, allorché me li ritrovo improvvisamente quasi tra le gambe. Temo sempre che ne possa nascere improvvisamente qualche monstrum, qualche miracoloso ente affine ai basilischi, per esempio. Sono faccende strane, anche preoccupanti se vogliamo, come certi libri antichi e polverosi, misteriose evenienze – per l’appunto – che quando sfuggono di mano non si sa mai come possono andare a finire. È terrorizzante, ad esempio, l’idea di poter incontrare in piazza, passeggiando serenamente, la generata prole di tali inconsueti casi, e magari trovarsi incoscientemente ad avere di che discutere con essi, senza che se ne palesi mai l’origine reale intendo. Sono affari preoccupanti, l’ho detto, ma altrettanto sono affascinanti, o quanto meno più interessanti di molte altre questioni banali solo apparentemente blasonate di fatua rilevanza istituzionale.
Mi interessano le assurdità, e – precisamente alla stessa stregua del mondo vegetale – le chiamo talvolta strutture sociali, in rapporto alla quotidianità civile. È qui che volevo giungere, mi sorrido quasi con autocommiserazione. L’umanità sopravvive solo nella forma consociativa, così come nelle piante riusciamo a intuire l’eternità, ciò in virtù di una ragionevole deduzione che affonda la sua analisi partendo dai semi, tutti uguali nella loro singolare individuazione, e nella generale definizione che nei termini assegniamo alla creatura definita: l’albero, l’uomo, e così via. Gli alberi sono alberi, gli arbusti sono arbusti, sì ci sarà il Mirto, il Faggio, e ancora distinguendo, ogni forma vegetale non è uguale alla sua vicina, tuttavia si chiudano gli occhi, come nell’argomento ornitologico, e si immagini un bosco. Riaperti gli occhi non sapremo mai dire quanti alberi abbiamo da numerare, e come differissero nella forma, confrontandoli tra loro. Per gli uomini è la stessa cosa. Insomma, siamo uguali e differenti anche noi, come tutti i carrubi e gli ulivi delle campagne iblee. E noi, uomini (forse uomini, e forse solo sogno), sussistiamo per mezzo delle relazioni, così come il mondo vegetale genera se stesso in continuazione. Nel dialogo, o meglio ancora nelle discussioni che avvengono ogni mattina in piazza, c’è il nerbo di una struttura suprema, costituzionale, che guai a intaccarla senza ponderarne accuratamente le conseguenze. Ogni piccolo gesto provocherà sempre, in ogni caso, delle mutazioni che riguardano il generale condiviso, nel bene e nel male. Più o meno a questo si dovrebbe pensare, quando si scorreggia nei luoghi chiusi (avrei potuto scrivere: “quando ci si esprime inconsultamente in flatulenze, data una eventuale circostanza pubblica”. Peccato, occasione perduta). Meno si parla in piazza, meno parole si intrecceranno tra loro, sempre di più il dialogo si approssimerà al silenzio. Dovremmo, in effetti, spingerci alla richiesta dialettica, anche solo per la curiosità di capire, ad esempio, se abbiamo a che fare con il figlio di qualche albero, o un semplice discendente dei pesci. Senza aggiungere che è comunque interessante procedere nell’indagine dell’assassino che ha emesso il peto.
È il sogno dell’alchimista quello di trovar la sintesi tra i due mondi succitati, quello vegetale e l’altro animale. Bonaviri ne ha fatto splendida letteratura, in prosa poetica. Ed è un lavoro tutto sommato attuale, oltre che a portata di mano. Esso non ha un vero culmine, per fortuna, o se ce l’ha corrisponde troppo al “monologo”; piuttosto è un processo che è meglio affrontare per approssimazione, come con il socialismo. Utopico auspicio, si diceva nei tempi antichi della filosofia. Proviamo nostalgia per gli dei, che non banchettano più con noi, l’abbandono ci ha reso tristi, a noi Feaci. Ma abbiamo ancora la forza di sperare nell’Insperabile, e affronteremo la disperata ricerca seguendo l’oscuro Eraclito, scettico anch’egli come noi. Essi, gli dei, si nascondono, forse sottoterra nei bulbi; e da qui il nostro timor panico. Ma essi potrebbero anche celarsi tra i passeggiatori in piazza. Forse dovremmo provare quella sana curiosità che ci risolleva dalla piattezza della superficialità facebookiana. Un buon strumento il social network, ma si rischia di farlo diventare contenitore di monologhi, stanza chiassosa di gente che sbraita a vanvera. Chissà invece che Pippino l’idraulico non sia un cultore del cinema Giapponese, o che Iachino l’intermediario immobiliare non abbia una passione smisurata per il Cinquecento italiano e magari ricordi a memoria qualche ottava del Furioso, e mi chiedo quanti sanno che Maria, la lavandaia, in privato si ispiri a Magritte per i suoi dipinti, quelli che nei suoi lunghi anni da single ha appeso ai muri del proprio appartamento, senza che nessuno ne abbia notizia. Sono dei mostri, questi e altri! Siamo tutti mostri, alla latina. Ma forse la strana magia sta tutta in una incompresa verità, e cioè che la poesia si fa schermo della banalità, retaggio delle bruttissime categorie borghesi. La curiosità disvela sempre una verità che ci fa paura, ma solo la coraggiosa ricerca produce quel reticolato di relazioni, coniugazioni in parte casuali, e incidentali coincidenze, fantasiose e semplici genialità; in pratica tutto quel che genera le storie che ci raccontiamo e tramandiamo, per aiutarci a vicenda, superando infine la caducità della individualità mortale.
Gaetano Celestre