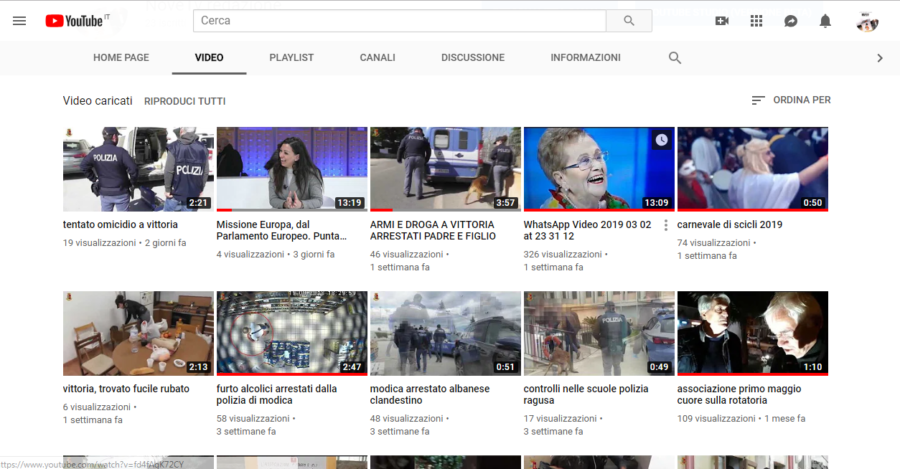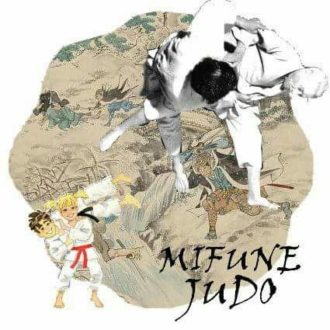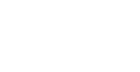In memoria di una strage. 5 anni fa il naufragio nel Canale di Sicilia
- 19 Aprile 2020 - 12:27
- 0
Di Andrea Gentile
 Il 18 aprile 2015, un vecchio peschereccio di legno, salpato dalla costa libica, navigava nel centro del Mediterraneo. A quasi cento miglia dalle isole di Malta e Lampedusa, con una telefonata, chiedeva aiuto. Il mercantile portoghese King Jacob, poco distante, veniva inviato a prestare soccorso, come già accaduto nei giorni precedenti.
Il 18 aprile 2015, un vecchio peschereccio di legno, salpato dalla costa libica, navigava nel centro del Mediterraneo. A quasi cento miglia dalle isole di Malta e Lampedusa, con una telefonata, chiedeva aiuto. Il mercantile portoghese King Jacob, poco distante, veniva inviato a prestare soccorso, come già accaduto nei giorni precedenti.
La missione europea Mare Nostrum è da poco conclusa. Sostituita da Triton, che prevede un minore coinvolgimento di mezzi di salvataggio. Le conseguenze mortifere della scelta sono dimostrate da immediati e continui naufragi.
Il peschereccio si avvicinava all’imponente mercantile, che generava onde alte metri. La massa di uomini a bordo oscillava, lo scafo si inclinava, l’urto diveniva inevitabile. Il peschereccio si rovesciava su un lato, imbarcava acqua e, lentamente, si inabissava.
In memoria di una strage. 5 anni fa il naufragio nel Canale di Sicilia
A bordo uomini, donne e bambini, in fuga dall’Africa e dall’Asia, dalla guerra civile libica e dalle sue prigioni, da violenze, torture e privazioni, che hanno pagato un biglietto per un viaggio disperato di sola andata. In ventiquattro sono portati in salvo a Catania. “Eravamo centinaia”, raccontano. Quarantotto corpi sono subito recuperati. Altri centosessantanove, da lì alla fine dell’anno.
L’anno successivo si innalza dal fondo del mare il relitto, che è trasportato a terra, in Sicilia. I vigili del fuoco recuperano i corpi rimasti all’interno dello scafo. Viaggiavano, sotto il ponte, nella stiva, ammassati l’un l’altro, in cinque in un metro quadro. Compressi e costretti, imprigionati e annegati, senza alcuna possibilità di salvezza. Il Labanof – il Laboratorio di patologia forense incaricato della complessa operazione di analisi per il riconoscimento delle vittime – utilizzerà seicentosettantacinque bodybags, sacche per corpi, o per le parti restanti. Saranno ritrovati passaporti, documenti, sacchetti di terra natia, fotografie, numeri di telefono, biglietti d’amore, anche una pagella scolastica piena di buoni voti. Solo in pochissimi saranno riconosciuti. Altro destino per gli altri, i cui familiari ancora attendono notizie.
In mille, il 18 aprile di cinque anni fa, perdevano la vita. Mille, in un solo naufragio, la più devastante tragedia del Mediterraneo.
Non una parola di umanità dagli esponenti della destra italiana più bieca e razzista, che invocava, anche di fronte a un tale dramma, il “blocco navale”. Il più abile, tra i vomitatori d’odio di professione, sarebbe persino diventato ministro negli anni a venire.
Cinque giorni dopo il naufragio i capi di stato d’Europa si riunivano straordinariamente. Alla fine dell’incontro, affidavano alla stampa cordoglio e promesse: “la situazione nel Mediterraneo è drammatica. L’Unione europea si adopererà con ogni mezzo […], la nostra priorità immediata è evitare altre morti in mare”.
Negli ultimi cinque anni, mentre la guerra in Libia diveniva più feroce ogni giorno, perdevano la vita dodicimila uomini e donne, nel tentativo di percorrere la rotta del Mediterraneo centrale, secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.
Nell’ultima settimana (almeno) dodici persone hanno perso la vita. Alcuni sono annegati, altri sono morti di sete, dopo cinque giorni di navigazione senza che giungessero i soccorsi (allertati e chissà quanto disperatamente invocati). Altri ancora avrebbero subito un sabotaggio dei militari maltesi, prima di essere catturati dalla presunta Guardia costiera libica e ricondotti nelle prigioni dove saranno di nuovo torturati.
Migliore sorte per quelli che sono riusciti a raggiungere autonomamente Lampedusa o Pozzallo – magari con l’aiuto di navi-madre, come accadeva in passato. I quattro ministri italiani non hanno fatto in tempo a decretare la chiusura dei porti – causa che ha visto negli anni l’impegno trasversale della maggioranza delle forze politiche italiane – per l’emergenza covid-19. Se nei mesi precedenti, con evidenti forzature del diritto internazionale, la Libia è stata ritenuta un “porto sicuro”, oggi l’Italia non è più considerata tale – né Malta, che ha subito copiato il decreto.
Altri ancora, centottanta in tutto, sono stati salvati dalle organizzazioni non-governative Sea-Watch e Aita Mari. I primi, dopo dodici giorni di peregrinazione, sono già a bordo di un traghetto (requisito o lautamente pagato?) ormeggiato al largo di Palermo, dove trascorreranno la quarantena. Gli altri si aggiungeranno a breve. Così, con favorevole congiuntura, è stato organizzato il primo hotspot galleggiante, che negli anni era stato solo proposto.
Due settimane fa, l’Unione Europea, la stessa che voleva “evitare altre morti in mare”, sostituiva la missione Sophia con la più recente Irini (Pace, in greco), che non ha tra i suoi obbiettivi il salvataggio. Agirà invece per impedire il traffico di armi e di petrolio in Libia e per formare e assistere la guardia costiera e la marina libica a “smantellare le reti di traffico […] e di tratta degli esseri umani”.
Dodicimila morti dopo, esattamente come cinque anni fa, oggi non c’è una sola imbarcazione pronta a salvare vite nel Mediterraneo centrale. Che sia di una guardia costiera, di una marina europea, o di una organizzazione non-governativa.