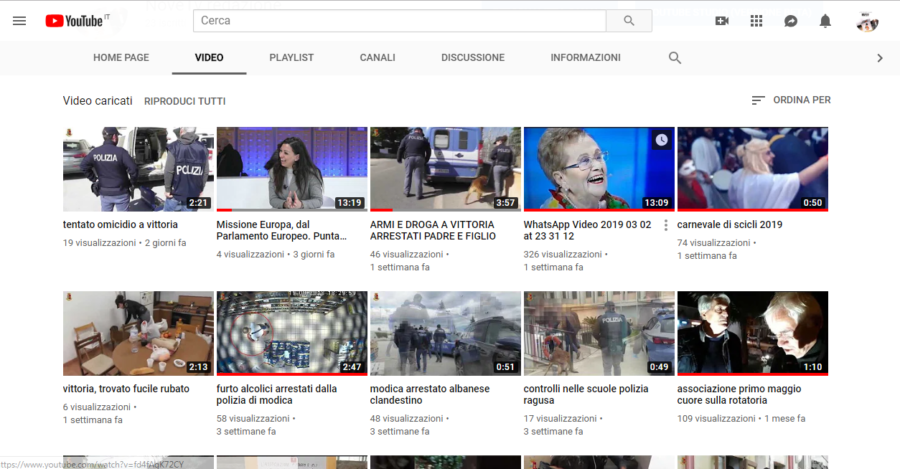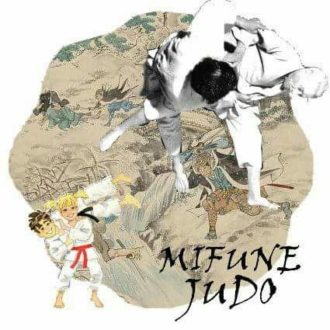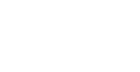Dicerie e Unzioni
- 25 Settembre 2017 - 15:57
- 0
Nell’opportunità offerta dal dibattito pubblico su Diceria dell’Untore, in previsione per oggi Lunedì 25-09-2017 presso la Libreria don Chisciotte alle ore 18:30, nel contesto delle consuete e amene attività del Gruppo di Lettura di Scicli, riporto di seguito alcuni appunti per una riflessione possibile ed eventuale (in foto: albero morente):
In alcune occasioni particolari, istanti che valgono eternità, capita di sentirsi toccare da dietro le spalle da sconosciute sottilissime dita, propaggini di ignote entità mai scorte e che pur si lasciano talvolta miracolosamente percepire. Rievoco taluni esempi concreti, ricordi dalla mia esperienza personale: resterà indimenticabile l’ecatea luna che, con naturale regalità, una notte di qualche anno fa sorse da dietro i morbidi iblei inondando di selenica luce il verecondo abbraccio che ancora mi congiunge alla adorata mia controparte femminile; i raggi lambivano la pelle bianca della venerata sorella sua, mentre io con pudicizia la stringevo al mio petto. E se dovessi, a memoria di vita vissuta, commemorare oggi il più religioso ed assoluto dei silenzi celebrati fino ad ora nei miei rituali di deambulazione – per quanto il silenzio, di qualunque tipo esso sia, pur sempre sarà da annoverarsi tra i rumori – non richiamerei il contesto di una chiesa gotica fuori dall’orario di messa, né una visita subacquea con boccaglio e maschera, ma piuttosto il sommesso ruminare della mascella impegnata sulle asperità fibrose di un frutto di carrubo secco, appena staccato dal dimenticato ramo che pende oltre il muro a secco, in una contrada sperduta dietro Mangiagesso; alla mia sinistra la strada ferrata e davanti – verso il ceruleo mare – la bianca lontanissima eppur necessariamente vicina cittadina. Sott’acqua, invece mi è accaduto qualcosa di significativo proprio nel corso di questa recente e ormai purtroppo trascorsa circostanza estiva: sono un nuotatore molto mattiniero, e da anni ripeto balneazioni solitarie in orari da terza età, ma mai come quest’anno mi sono sentito improvvisamente in sintesi rispetto il mondo sottomarino, ciò è successo in una data particolare, allorquando gli strali solari, obliqui e ficcanti, trafiggendo la superficie equorea, da quel momento donavano brio a un mondo che davo scontatamente per spento, in tal modo s’accendeva d’un tratto un mesto circostante; vita di sciami vibranti di argentine scaglie, di granchi che sorgono dalle sabbie ondulate, di occhi appaiati che si aprono sullo stesso lato del proprio corpo poggiato sul fondale; senza aver paura dell’intruso, mi attraversavano nuvole di tigrati pesci, con curiosità mi scrutavano i cefali (i mulet così utili a sostanziare il cous cous berbero); così appuravo che la vivacità non è altro che un’aggiunta alla stagnazione, anzi addirittura che le due pulsioni non si affrontano in una negazione reciproca, ma si costituiscono in una dialettica di contrasto, in equilibrio di operazione permanente; è una formula matematica, non una cifra già ricavata o chissà da dove rinvenibile in simboli esatti.
//
Sono solo alcuni esempi, ne avrei altri, ma tre è il numero che mi basta per porre in rilevo quell’alchemico “ammiscari” cui si fa cenno nella “Diceria”, una volta con la parola, e in continuazione nei fatti narrati, non più oltre mentovandola. Così accade la vita, tra Eros, quale pulsione – quasi “coazione a ripetere” – e consapevolezza di decadenza in itinere, Thanatos. Tuttavia, ed è qui che occorre porre l’attenzione, solo in un preciso istante tutto appare “mescolato”, perfettamente in equilibrio, laddove si può sentire la completezza nell’unità della coscienza che opera la sintesi appercettiva. Ma quanto durerà mai un tale baleno estatico? Tempo di finir di scorrere le pagine di un libro, probabilmente, nel migliore dei casi. Seguiamo, come uomini, la tensione alla vita, pur sapendo che sfuggiremo alla cavallerizza senza naso solo per qualche attimo ridicolmente fatuo. Poi saremo catturati, sarà il suo trionfo, sempre e comunque. Dovremo pur farcene una ragione, prima o poi. La malinconica consapevolezza della fine scritta ci dovrebbe rendere più sereni, infine propensi ad avvicinarci a palazzo Sclafani con auspicabile leggerezza, o magari con il sarcasmo utile a farci sollevare le labbra fino ad un sorriso di compiacenza e con diplomatico garbo. Sfrontati mai, non come il Gran Magro, forse questo no. Anche se la figura del nobiluomo Mariano Grifeo Cardona mi seduce, lo ammetto. Anch’io, talvolta, come Voltaire, vorrei indignarmi al cospetto di dio, per il Suo meschino comportamento irriguardoso nei confronti dell’Umanità, alzarmi e voltargli le spalle, rifiutare persino i suoi doni salvifici, come il terremoto di Lisbona, rimproverarlo duramente, acremente!, fino alla commiserazione. Il rischio di una mera sostituzione allo Stesso vorrei però evitarlo: “Il Gran Magro irradiava, sette giorni su sette, da una sua profonda officina, con la pretesa di assopirci o svegliarci a suo gusto secondo le decisioni di una manopola lontana.” Questi sono soprusi da divinità da operetta, destinate alla sconfitta; indignitose brame del tutto affini alle vili scorribande che lo stesso medico blasfemo depreca e rimprovera agli altri residenti olimpici. Più probabilmente la serenità sarà simile a quella dell’uomo involontario, immerso nell’innocenza , come il religioso Vittorio, colto sulla via per la Damasco celeste da incertezze e penosi sospetti riguardo la “passione” di Cristo (la prima venuta, che sia una scusa per farsi perdonare Egli medesimo, per salvarsi prima ancora che salvare qualcuno?). I fanciulli, invece, che non conoscono dogmi di fede e dubbi sugli stessi, essi sì che sono esseri involontari, esemplarmente tratteggiati tra le pagine nel macabro esercizio dei loro giochi, e poi – stremati dalla fatica dei molli girotondi sfiatanti attorno ai tronchi d’albero – correttamente disposti a discutere tra loro di misteri.
In processione, nel pieno del corteo funebre, ci coglie l’amore, anche quello miserevole e grandioso che riserviamo infine a noi stessi, all’impalcatura traballante di quel che abbiamo fatto di noi medesimi; si tratta dell’intimo affetto di chi vuole essere ricordato per sempre e – mancando la possibilità di un supporto elevato ed ideale, dell’eclatante foscoliano, per ragioni di deficienza di merito o di forma – finisce per accontentarsi di improvvisare qualcosa di notevole sul momento, col piede già pendente sul ciglio della fossa, e allora uno schiaffo, una oscenità, una bestemmia, una indecenza qualunque, la volgarità di una eruttazione purulenta e nauseabonda proferita senza motivo all’orecchio di un bambino incontrato per strada, una di quelle scurrilità che non si scordano facilmente, in saecula saeculorum, sino all’unzione di cattiveria gratuita nelle case degli amici, soprattutto degli amici, ché dei nemici ormai importa poco, questa è la forma cristologica dell’annichilimento che verrà. Se poi davvero codesta terribile seconda venuta in gloria ci sarà, chissà!?, sono più propenso a credere che l’ambizione di una simile parusia potrebbe (dovrebbe) restar delusa. Eppure, senza troppe ipocrisie, occorre essere chiari tra noi che ne stiamo parlando (scrivendo e leggendo) e accettare che molti di noi (non vorrei mai pensare “tutti”) si fingono unti da grazie speciali, nella propria personale religione. Chi conta, oltre se stesso, quando si sta per morire? Se lo chiede Marta, rispondendosi senza esitare: “Voi, gli altri, siete appena barlumi e finzioni che sento respirare e parlare al mio fianco.” Lo spazio, per dirla con Kant, è presupposto mediante il quale il senso esterno riesce a rappresentarsi gli oggetti che stanno fuori di noi. Il senso interiore invece agisce sul tempo come rappresentazione necessaria e fondamento di tutte le intuizioni (non è un concetto empirico); Marta sa che entrambi gli aspetti sono finzioni soggettive, condizioni universali della “possibilità”: “Penso che se uno potesse correre più presto della luce e sopravanzarla e fermarsi ad aspettarla in qualche stazione di stella, vedrebbe replicarsi per intero tutto il rotolo del passato. Mi consola pensare che in un raggio ancora in cammino c’è lui che mi bacia e mi parla, e che qualcuno in capo al cielo non sa ancora ch’è morto.” Marta vorrebbe alterare la stessa sua percezione in maniera duratura, eludendo il giudice supremo della coscienza unitaria e la sintesi realistica operata dallo stesso, ma non vi riesce. Se non è la filosofia pratica morale, sarà sempre la biologia a fermarci. Così chi è assunto del tutto, completamente e consciamente, nel regno di Thanatos, non ha più interesse a confrontare individuali sensazioni in conviviale reciprocità, con gli altri. Ed è un vero peccato, poiché sarebbe quello un momento propizio a commiati provvisori e progetti riorganizzatori sereni. Si slegano invece i rapporti dell’uno con il tutto, volente o nolente che sia l’ente in via di defunzione. Nell’altro regno, quello di chi si salva – chi scampa anche solo momentaneamente alla cavallerizza senza naso – all’ente che si avvicina al tutto non resta che ridiscendere dalla Montagna Magica: “Bisogna che parta, mi dissi, troppo tempo ho perduto fra i morti, simulandomi morto, scordandomi dell’ironia.”, e tentare di stringere nuovi rapporti più fecondi con le cifre che sostanziano l’indagine sulla formula della vita.
Gaetano Celestre